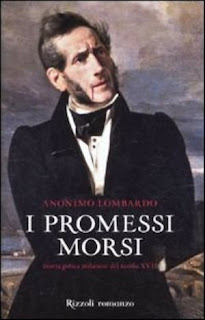La vita
Alessandro Manzoni nasce il 7 marzo 1785 a Milano, da Pietro Manzoni (padre putativo, quello vero essendo probabilmente Giovanni Verri) e da donna Giulia Beccaria, figlia del celebre marchese illuminista Cesare Beccaria, autore del trattato Dei delitti e delle pene. Dopo la separazione dei genitori viene mandato dalla madre nel collegio gestito dai padri somaschi in Brianza e successivamente dai barnabiti a Milano. Tutta la sua adolescenza sarà contrassegnata da tali tetri educatori, che tuttavia lo iniziarono alla cultura classica, alla conoscenza degli autori latini tra i quali in primo luogo Virgilio, nonché di Dante e di Parini. «Il Manzoni ha avuto tragici rapporti coi genitori, specie con la madre (cosa che l’ha costretto, tra l’altro, a passare lunghi anni in collegio). È semplice per noi posteri, lettori di Freud, analizzare la conseguente nevrosi che è caratterizzata dall’eterna forma di complesso nei riguardi del sesso femminile (le vertigini che egli provava, solo se seduto su una sedia isolata, ne sono un sintomo “da laboratorio”): ciò non poteva che portarlo a una cristallizzazione della femminilità, condizione senza la quale sarebbe stato impossibile per lui pensare al rapporto sessuale. […] La vita sessuale – dice Freud – non è un fiume che scorre sul suo letto, ma è un rivolo di liquido vischioso, pieno di rami, pozzanghere, e solo faticosamente il suo corso principale giunge al proprio sbocco.
«L’omosessualità di Manzoni era evidentemente uno di questi corsi secondari, di queste pozzanghere: ma è sotto il suo segno che si svolge tutto il fitto intreccio di rapporti dei personaggi dei Promessi sposi» (Pier Paolo Pasolini, Descrizioni di descrizioni).
A Milano entra in contatto con Vincenzo Monti, riconoscendo in lui un vero e proprio ruolo paterno, dedicandogli anche alcuni versi. Terminati gli studi trascorre qualche tempo nella casa paterna, frequentando circoli dove conosce Ugo Foscolo, Vincenzo Cuoco e Francesco Lomonaco.
In seguito, coltiva un interesse per la storia e per la letteratura componendo testi di stampo neoclassico, poi viene mandato a Venezia per essere sottratto all’influsso della Milano napoleonica. Nello stesso tempo muore Carlo Imbonati, amante della madre. Manzoni per invito di Giulia si reca a Parigi dove scrive il suo primo testo di rilevo, il carme In morte di Carlo Imbonati.
Da questo momento, inizia a dedicarsi a un programma di vita legato a un’etica laica di alto profilo morale, che egli non rinnegherà neanche dopo la discussa conversione: «il Carme si annunzia come un programma limitato sibi et paucis: con l’implicito riconoscimento, ancora più categorico che storico, della frattura insormontabile che da sempre condannava l’intellettuale italiano ad una sorta di perpetua alienazione nei confronti del proprio retroterra “popolare”.
«E intanto ne restava stimolata, a livello esistenziale, una nativa asocialità, che si può riempire di motivazioni culturali e psicanalitiche di più larga estensione (dal rousseauvismo all’agorafobia), ma che per l’appunto negli anni che vanno dal Carme alla conversione resta in evidenza anche come nodo traumatico di un oggettivo vuoto generazionale, confermato da molte biografie parallele, nel trionfo della retorica napoleonica e nel restringersi d’ogni alternativa» (Giancarlo Mazzacurati, Per un diaframma tardo-illuministico: Manzoni tra il Carme in morte di C. Imbonati e l’Urania, in Forma & ideologia).
A Parigi frequenta i salotti intellettuali dopo aver ricevuto un’educazione cattolica rigida ma, particolare spesso dimenticato, con idee illuministiche. Che il cattolicesimo in sede culturale e letteraria debba essere sfrondato anche da un pregiudizio laicista, peraltro legittimato purtroppo da una bieca tradizione scolastico-provinciale che tuttora agisce, è d’altra parte una necessità manifestata da una riflessione critica ulteriore, a partire proprio dal “laico in tutti i sensi” che fu Manzoni. «Fu inoltre considerato padre inetto e incapace di indirizzare a una professione i figli, - ha scritto Salvatore Silvano Nigro - che si indebitarono e lo indebitarono. Cattolico per nulla filisteo, e anzi “laico in tutti i sensi” e sostenitore – nella seconda parte delle Osservazioni sulla morale cattolica - della compatibilità della religione cattolica con lo spirito del secolo da dirigere e da correggere, fu contrario al temporalismo del corpo giuridico della Chiesa: difatti, tra la scandalizzata protesta dei cattolici intransigenti, non esitò in qualità di senatore del regno d’Italia a votare in favore del trasferimento della capitale da Torino a Firenze, come tappa intermedia verso la predestinata Roma, né ad accettare nel 1872 – nello spirito della legge delle Guarentigie fondata sul principio della separazione tra Stato e Chiesa – la cittadinanza onoraria offertagli dal comune di Roma.»
Alessandro incontra così la dimensione religiosa, conosce la donna che rivestirà un ruolo importante nella sua vita coniugale: Enrichetta Blondel. In questo stesso periodo, durante il matrimonio di Napoleone con Maria Luisa d’Austria, tra la folla perde la moglie e si va a rifugiare nella chiesa di S. Rocco pregando affinché Enrichetta ritorni; quando la ritrova, si attribuisce proprio a questo episodio la conversione al cattolicesimo ma in realtà fu semmai un ritorno alla fede. Comincia ora la sua maturità artistica e grazie alla cospicua eredità lasciatagli dal padre e da Carlo Imbonati fissa la sua dimora a Milano.
Nel 1819 la famiglia Manzoni si trasferisce di nuovo per un determinato periodo a Parigi dove lo scrittore incontrerà molti personaggi da cui prenderà ispirazione per le sue opere.